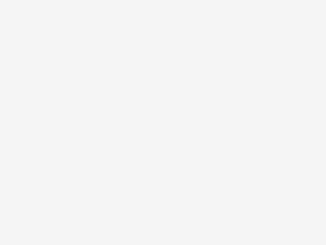Che le pensioni fossero diventate un miraggio sempre più lontano ed irraggiungibile, già si sapeva ma qualcosa di buono, in quello che sembrava un panorama del tutto negativo, a quanto pare c’è.
E’ proprio l’allungamento dell’età minima delle pensioni che rende l’importo della pensione stessa non così basso: potrà essere pari al 70% dell’ultimo stipendio per un lavoratore dipendente e del 57% per un parasubordinato.
Questa stima deriva dal metodo di calcolo contributivo che si applica a chiunque abbia cominciato a lavorare dopo il 1995: più anni di contributi si versano, più tardi si va in pensione, e più si prende.
Il calcolo presunto era sempre stato fatto considerando i parametri precedenti: 58-60 anni per la pensione di anzianità (con 35 anni di contributi) e 65 per quella di vecchiaia (60 per le donne). Ma per chi comincia a lavorare oggi, le cifre sono molto diverse.
Un giovane che si sta avviando al lavoro andrà in pensione nel 2046, a 65 anni e 3 mesi, ma solo se avrà i 35 anni di contributi. Altrimenti l’attesa si prolungherà fino a 69 anni e 3 mesi, per la vecchiaia. Dunque, ciò significa che anche chi smetterà di lavorare a quell’età avrà versato contributi per 35 anni.
E’ questo il calcolo che ha fatto Stefano Patriarca, responsabile dell’area pensioni dell’ufficio studi dell’Inps in un rapporto che verrà presentato oggi alla Scuola superiore di economia e finanze Ezio Vanoni.
Patriarca conosce a fondo il metodo di calcolo contributivo, poiché è stato uno dei fautori dello stesso, in qualità di membro della commissione tecnica che preparò la riforma Dini-Treu del 1995.
Quindi proprio lui, rifacendo i calcoli alla luce delle ultime novità legislative, ha scoperto che la situazione previdenziale dei giovani è meno peggio di quanto si immaginava.
Lo stesso Patriarca commenta così i risultati della sua ricerca: “Non è tanto ma non è neppure il 30% di cui si parlava prima. Semmai il problema è che se la retribuzione è bassa allora la pensione potrebbe non essere sufficiente, ma questo riguarda il mercato del lavoro e non il sistema previdenziale, perché non si possono avere pensioni ricche se le retribuzioni sono povere“.
In ogni caso, aggiunge, l’ipotesi di un precario a vita riguarda una ristretta minoranza. Già simulando la pensione di un lavoratore discontinuo (10 anni in nero, 6 da parasubordinato e 22 di lavoro dipendente), si arriverebbe a un assegno pari al 59% dell’ultima retribuzione.
Occorre puntualizzare che lo studio si basa su tassi di copertura al netto delle tasse e non al lordo, come si fa di solito, e poiché sulle pensioni non si pagano i contributi e si versano meno imposte che sulla retribuzione, ecco che il tasso di copertura se ne giova.
Inoltre, bisogna considerare il Tfr che aumenterebbe il tasso di copertura di 13 punti, in caso di carriera contributiva piena. Ciò significa che i fondi pensione integrativi non sarebbero così indispensabili per assicurare ai giovani una pensione, e quindi una vecchiaia, dignitosa. Piuttosto, sarebbero consigliati per i mercati di lavoro più deboli, che non potrebbero neppure fare affidamento sugli accantonamenti per la liquidazione, i Tfr appunto.
Conclude Patriarca: “La vera emergenza non è rappresentata dalle pensioni di un generico universo giovanile, ma dalle condizioni di lavoro di aree ben definite ma drammatiche, a partire dal lavoro nero e dalle nuove partite Iva. È qui che bisogna intervenire. Quanto al resto, bisogna dire una volte per tutte che il vecchio mix anzianità-sistema retributivo, che ancora si applica alla stragrande maggioranza dei nuovi pensionati, chi nel ’95 aveva meno di 18 anni di servizio, è insensato“.
Vera Moretti